Femminicidio, riflessione linguistica di una violenza
Sara, bruciata da uomo che era stato il suo fidanzato, è solo l’ultima vittima di quello che definiamo femminicidio.
Come molto spesso accade, è la realtà a dare forma alla lingua, così come alla legge, e non viceversa. Il termine femminicidio è un neologismo figlio di una società al tempo stesso carnefice e vittima, che si ritrova distruttiva e sensibile ad ogni nuovo delitto, ad ogni nuova perdita.
Al grido di #saranonsarà, ci aggrappiamo ad un gioco di parole e quindi alla lingua, e alla cultura, per cercare di comprendere, o forse solo di accettare, qualcosa che è al contempo vicino e lontano da ognuno di noi. Ma lo facciamo con un errore, imperdonabile, di mischiare sensibilità e processo penale, soggettività e società, anche virtuale. Un grande calderone di emozioni e reazioni, che finiscono per prendere fuoco e gettare fumo negli occhi di chiunque. Pensiamo a Sara come ad una vittima italiana, donna, una vittima d’amore. Ma, con motivate ragioni, facciamo fatica ad inserire l’evento in un quadro generale, culturale, che supera confini invisibili e nazionali.
Torniamo per un attimo alla complessità linguistica. E alla traducibilità, non solo delle parole in eventi, ma anche di una lingua in un’altra. Alcune parole sono intraducibili perché descrivono ed esprimono sintomi culturali, locali, talmente ristretti a volte da essere inspiegabili al di fuori di quei confini che contaminano. E’ evidente però, che il mondo in cui viviamo oggi, fatto di interrelazioni, collegamenti wireless e voli transoceanici, ci restituisca fenomeni globalizzati, o meglio, universali. Parlare di globalizzazione significa appiattire l’evento, le sensibilità culturali. In questo caso invece, ogni morte è figlia della sua cultura. Quella religiosa in certi Paesi arabi, quella liberale in occidente, quella della crisi di valori (e parimenti economica) in Sudamerica. Ma, infine, sono tutte conseguenze della stessa logica, quella della superiorità del fallo. Del machismo culturalmente indotto e della dominazione perbenista, che prevede la prevaricazione e la giustifica, raccomandandosi con le sue vittime di tenerla nascosta, perché così è e deve andare.
Sara non è diversa dalla ragazza drogata e stuprata in Brasile da un gruppo di trenta uomini, dalle decine di donne violentate e molestate a Colonia, dalle ragazze somale vittime di abusi durante l’epidemia di ebola e chissà quante altre.
in Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa, nella maggior parte dei casi da qualcuno che fa o faceva parte del suo nucleo più intimo, familiare. Così nel mondo, il 65% delle donne ha subito almeno una volta nella vita una violenza.
Un fenomeno talmente diffuso da non poter essere ignorato. Ancora una volta però, fermarsi ai dati risulta limitante e può essere utile allargare il discorso per evitare pericolosi boomerang. Il problema non si esaurisce nell’identità di genere. La prevaricazione, figlia del pilastro portante delle relazioni umane, homo homini lupus, continua dominare i rapporti, economici, politici, familiari, sentimentali. La debolezza rimane sintomo di rinuncia e motivo di sopraffazione. Sara, e le altre, non sono diverse dai timidi vittime dei bulli, dai malati e anziani picchiati in strutture che dovrebbero garantire la loro protezione, dai bambini castigati dalle maestre. Si tratta sempre della determinazione in principio di una condizione di inferiorità.
Certo, come precisa l’Accademia della Crusca, il termine indica un ribaltamento di prospettiva. Come se ci si fosse destati di fronte ad un evento che è sempre accaduto. Come se, svegliatici in un’improvviso stato di coscienza, avessimo capito che l’assassinio di una donna, magari madre, o moglie, o figlia, non possa essere considerato normale, accettabile.
E noi, ora coscienti di questa anormalità, in che modo ne parliamo? Quali esseri umani multitasking e portatori di intelligenze tecniche, non chiediamo più alla filosofia di spiegarci la complessità del mondo. Il nostro tramite, tra l’esistenza soggettiva e l’universalità sono la televisione, i giornali, e soprattutto i social network. E qui ritorna il ruolo della lingua. A che pro arricchirla di un termine indicativo di una crescita culturale se poi si rimane intrappolati in logiche ataviche e medievali?
E’ chiaro come il linguaggio influenzi la percezione dell’evento e la sua comprensione.
Fano, uccide la moglie in un raptus di gelosia. “L’uomo […] ha accoltellato la donna, che ha tentato di difendersi inutilmente, dopo un violento litigio davanti ai quattro figli…”.
Scrive Michela Murgia a proposito di questo titolo: «Nel giornale che vorrei, la notizia sarebbe stata data così: Fano, giovane donna uccisa a coltellate davanti ai suoi figli e poi “Arrestato l’autore del violento femminicidio: era il marito”».
E’ palese che allora il rischio di questa consapevolezza culturale, almeno accennata, possa immediatamente essere ribaltata in un nuovo senso di colpevolezza.
Passiamo dagli orchi alle streghe con la stessa facilità con cui viaggiamo da New York a Tokio. Continuiamo ad occupare il ruolo della giustizia, che si dovrebbe risolvere e concludere nei tribunali, rinunciando consapevolmente al ruolo che invece ci spetterebbe, quello della comprensione, del cambiamento. Senza una cultura che ci permetta di comprendere quello che conquistiamo e perdiamo ogni giorno, finiamo per perderci nella complessità del mondo che il genio dell’essere umano riesce a costruire. Perché d’altra parte, restiamo animali. La mancanza di cultura relazionale e sessuale, fa nascere rapporti basati sulla paura, sull’obbligo, sulla contingenza. E, che finiscano o meno con una o più vittime, rappresentano comunque il fallimento della crescita dell’essere umano.
La 16enne brasiliana drogata e violentata da almeno 30 uomini, tra cui un giovane calciatore, ha usato queste parole. «So che non ci sarà giustizia, che mi dovrò vergognare. In un primo momento non volevo neanche dirlo a mia madre». Non chiede vendetta, ma vuole essere libera di sentirsi vittima e di poter uscire da questa condizione. E’ viva, al contrario di Sara, e sta chiedendo aiuto, come aveva fatto Sara. Ma noi siamo disposti ad aiutarla o preferiamo indagare sulla sua dubbia moralità?

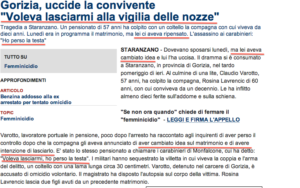



+ Non ci sono commenti
Aggiungi